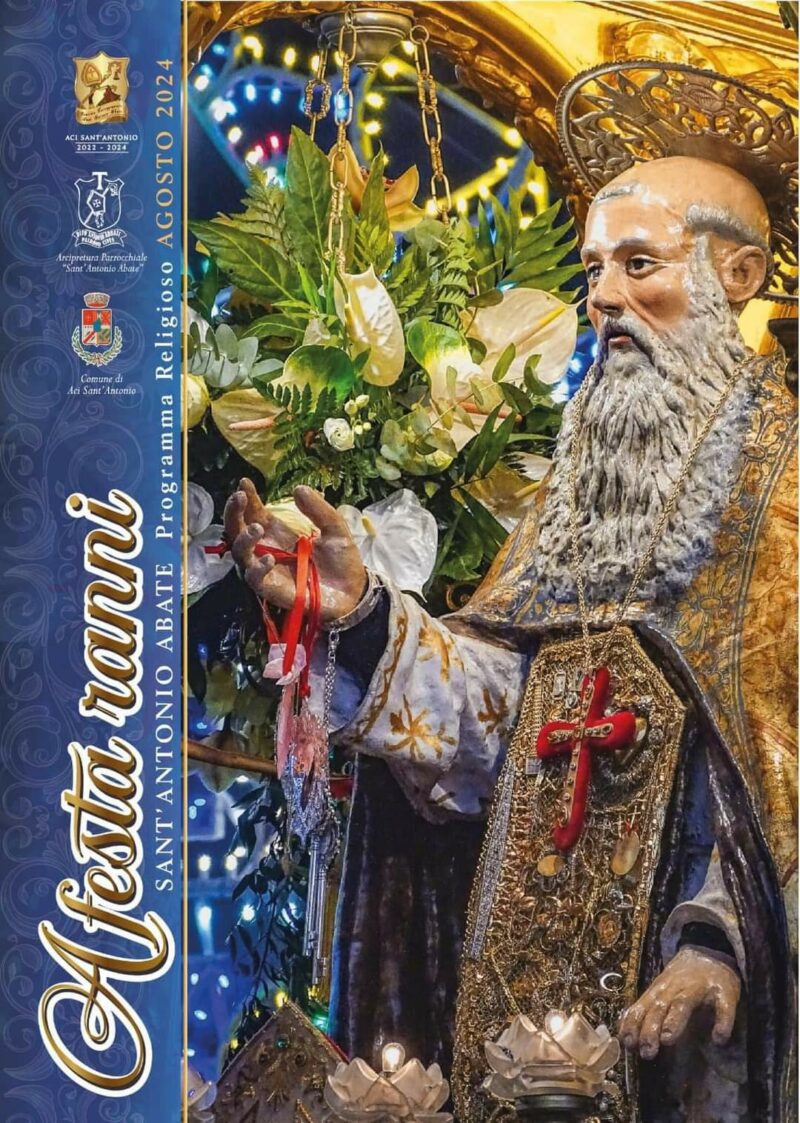Sant’Agata, secondo la tradizione cattolica, fu una giovane cristiana vissuta nel III secolo in Sicilia, durante il periodo delle persecuzioni cristiane.
Oltre che come un esempio di perseveranza, resistenza e fede incrollabile, i fedeli venerano Sant’Agata come simbolo di lotta contro la violenza sulle donne.
Il suo rifiuto di sottomettersi alle pressioni e alle minacce del proconsole Quinziano, nonché la sua ferma determinazione nel mantenere la propria fede e integrità, rappresentano una forma di lotta contro l’abuso e l’oppressione.
Agiografia e contesto storico
Il fatto che sia considerata una delle martiri più venerate dell’antichità, influenza fortemente il considerare Sant’Agata come simbolo di lotta contro la violenza sulle donne. La giovane cristiana infatti fu torturata e martirizzata durante la persecuzione voluta dall’imperatore Decio nel III secolo, per non aver mai rinunciato a professare la sua fede.
Il suo martirio testimonia come a Catania già nel III secolo esistesse una comunità cristiana. Altra conferma proviene dal rinvenimento a Catania nel 1730 di un’iscrizione datata tra la fine del III secolo e gli inizi del IV che segnalava la sepoltura di Iulia Florentina, una bambina di Ibla, sepolta, per volere dei genitori, «dove sono le sepolture dei martiri cristiani». Tale iscrizione è una testimonianza importantissima circa l’immediata diffusione del culto di sant’Agata, dopo la sua morte, non solo in città, ma anche fuori dal territorio etneo.
Controversie sulle origini
Secondo gli atti del martirio, Agata nacque in una famiglia ricca e nobile, per tradizione catanese. La località di nascita è stata in passato motivo di discussione: l’ipotesi iniziale, secondo la quale fosse nata a Palermo, fu smentita per errata trascrizione, accreditando invece l’ipotesi che trattasi di Galermo, a nord di Catania.
I documenti narrativi del martirio di Agata in realtà tacciono sui suoi natali, ma indicano in tre punti i sostanziali indizi sulle sue origini catanesi:
- Primo punto: il testo narrante il processo, fornito dalla redazione latina, esordisce affermando che Agata fu martirizzata a Catania. Esso afferma che, quando Quinziano interpellò Agata invitandola a dichiarare di che condizione fosse, lei rispose «Io non solo sono libera di nascita, ma provengo anche da nobile famiglia, come lo attesta tutta la mia parentela». Con questa affermazione Agata fa intendere che tutta la sua famiglia, quindi le sue origini sono catanesi.
- Secondo punto: si riferisce all’apparizione dell’angelo che depose una lapide di marmo nel luogo di sepoltura della Santa. Sulla lapide era scolpito «anima santa, onore di Dio e liberazione della sua Patria». A questo proposito, per dimostrare che la Patria cui si riferisce è Catania, si ricorda che ad un anno dalla sua scomparsa, Dio fa arrestare la lava dell’Etna che puntava dritta sulla città.
- Terzo punto: relativo al fatto che il testo della redazione greca, riportato nel manoscritto del Senato di Messina, espressamente recita che «Catania è la patria della magnanima S. Agata». Tale testo è di assoluto valore storico perché risale all’epoca in cui a Catania ancora non era stato eretto alcun tempio a Sant’Agata.
Controversie sulla data di nascita
Anche sulla data di nascita di Agata, taciuta dalle fonti, di conseguenza, non esiste un’assoluta certezza. La tradizione popolare colloca però l’età della fanciulla nella fascia adolescenziale durante il suo martirio, attribuendole 15 anni. Recenti ipotesi, però, retrodatano la nascita della Santa, facendo riferimento al flammeum (il velo rosso del sacerdozio del primo cristianesimo) e al ruolo di diaconessa che le viene attribuito dalle prime rappresentazioni iconografiche. Tale ruolo infatti veniva concesso alla maggiore età dell’epoca, che corrispondeva a 21 anni. Come riporta la tradizione, Agata aveva richiesto di consacrarsi a Dio al Vescovo di Catania, che accolse il suo desiderio e le impose il velo rosso portato dalle vergini consacrate.
Inoltre, da un punto di vista giuridico, Agata aveva il titolo di “proprietaria di poderi”, cioè di beni immobili. Per avere questo titolo, le leggi in vigore nell’impero romano pretendevano il raggiungimento del ventunesimo anno di età. Rimanendo sempre in tema giuridico, durante il processo di Agata, fu messa in atto la Lex Laetoria, una legge che proteggeva i giovani d’età compresa tra i 20 e i 25 anni, soprattutto le giovani donne. Secondo quanto sancito dalla legge chiunque aveva la possibilità di contrapporre una actio popularis contro gli abusi di potere commessi dall’inquisitore. Difatti il processo di Agata si chiuse con una insurrezione popolare contro Quinziano, che dovette fuggire per sottrarsi al linciaggio della folla catanese.
Dunque è plausibile affermare che nel giorno della sua morte, Agata avesse già compiuto 21 anni.
Il processo
Tra il 250 e il 251 d.C. il proconsole Quinziano, giunto alla sede di Catania con l’intento di far rispettare l’editto dell’imperatore Decio (che chiedeva a tutti i cristiani di abiurare pubblicamente la loro fede), mise in atto una feroce persecuzione. La tradizione riferisce che Agata fuggì con la famiglia a Palermo, ma Quinziano li scovò e li fece tornare a Catania. Il punto che la giovane catanese attraversò per uscire da Palermo e tornare alla sua patria, oggi è detto Porta Sant’Agata. Non appena vide la fanciulla, Quinziano se ne invaghì e, venuto a conoscenza della sua consacrazione, le ordinò di ripudiare la sua fede e adorare gli dèi pagani, ma senza successo.
Al rifiuto deciso di Agata, il proconsole decise di affidarla per un mese alla custodia rieducativa della cortigiana Afrodisia e delle sue figlie. È possibile che Afrodisia fosse una sacerdotessa di Venere o Cerere, e pertanto dedita alla prostituzione sacra.
Il fine di tale affidamento era la corruzione di Agata, attraverso una continua pressione psicologica, fatta di allettamenti e minacce, per sottometterla alle voglie di Quinziano, arrivando a tentare di trascinare la giovane catanese nei ritrovi dionisiaci ed orgiastici. Ma Agata ne uscì più forte di prima, tanto da scoraggiare le sue tentatrici, le quali rinunciarono all’impegno assunto, riconsegnandola al proconsole.
Rivelatosi inutile il tentativo di corromperne i principi, Quinziano diede avvio a un processo e convocò Agata al palazzo pretorio.
Le torture e il martirio
Il passaggio che condusse Agata dal processo alle torture fu breve. Nel tentativo di piegare la sua ferma volontà, Quinziano rinchiuse la fanciulla in carcere, nel luogo in cui oggi sorge la Chiesa di Sant’Agata al Carcere. Durante la sua reclusione, la fanciulla fu condotta più volte al cospetto del proconsole per essere fustigata. A Catania, nella chiesa di Sant’Agata la Vetere si conserva il luogo indicato come sala del pretorio romano dove vennero eseguite le torture e i processi.
In seguito le torture divennero sempre più crudeli: fu legata sull’eculeo e allungata con funi fino a slogarle le caviglie e i polsi, dopodiché venne sottoposta al violento strappo delle mammelle con le tenaglie. Le passio di Sant’Agata riportano le parole che la martire disse al proconsole: «Empio, crudele e disumano tiranno. Non ti vergogni di strappare ad una donna quello che tu stesso succhiasti dalla madre tua?».
La notte seguente allo strappo dei seni, secondo la tradizione, Agata venne visitata da San Pietro, che la confortò e ne risanò miracolosamente le ferite. Il giorno dopo fu condotta al cospetto di Quinziano che, umiliato da quella strenua resistenza e dalla guarigione miracolosa, dispose che la fanciulla fosse sottoposta al supplizio dei carboni ardenti e bruciata viva.
Quel giorno, tuttavia, durante l’esecuzione, un violento terremoto scosse la città di Catania, interrompendo il supplizio e facendo riportare Agata nella sua cella ormai agonizzante, dove spirò la notte seguente, il 5 Febbraio 251 d.C.
La tradizione vuole che i consiglieri di Quinziano, anch’essi carnefici, siano morti durante il terremoto, mentre il proconsole, inseguito dalla folla in rivolta, morì inghiottito dalle acque del fiume Simeto. Il suo corpo non fu mai ritrovato.
La chiesa di San Biagio, conosciuta a Catania anche come chiesa di Sant’Agata “alla fornace”, conserva nell’altare laterale della cappella della Santa, le pietre e la terra che secondo la tradizione la tormentarono proprio nell’ultima esecuzione.
Le reliquie
Nel 1040 d.C. il generale bizantino Giorgio Maniace trafugò le reliquie della Santa per portarle a Costantinopoli. Nel 1126 d.C. i soldati Gisliberto e Goselmo, precedentemente in servizio nell’esercito bizantino, rubarono i resti della martire per restituirli al Vescovo di Catania Maurizio. La consegna avvenne nel Castello di Aci, l’odierna Aci Castello.
Il 17 agosto 1126 d.C., le reliquie rientrarono nel Duomo di Catania. Questi resti sono oggi conservati in parte all’interno del prezioso busto in argento (parte del cranio, del torace e alcuni organi interni), opera del 1376 dell’orafo senese Giovanni di Bartolo e in parte dentro a reliquiari posti in un grande scrigno, anch’esso d’argento (braccia e mani, femori, gambe e piedi, la mammella e il velo), opera del catanese Vincenzo Archifel.
Il busto reliquiario
Il busto reliquiario di Sant’Agata è un capolavoro dell’oreficeria medievale, realizzato in argento sbalzato con smalti policromi e contiene le reliquie della santa, tra cui la cassa toracica e il teschio.
Il busto è adornato con oltre 300 gioielli e ex voto, donati dai fedeli nel corso dei secoli. Alcuni dei gioielli più notevoli includono:
- La corona donata dal re inglese Riccardo Cuor di Leone, che la regalò durante una sosta a Catania nel suo ritorno da una crociata.
- Una collana del XV secolo incastonata di smeraldi, donata dal popolo di Catania o attribuita al viceré Ferdinando De Acuna.
- La croce del Cardinale Nava, un’opera riccamente lavorata del XVI secolo.
- Il collare della Legion d’Onore francese, appartenuto al musicista catanese Vincenzo Bellini, donato dai suoi familiari come ex voto.
- Un anello appartenuto alla regina Margherita, donato durante una visita a Catania nel 1881.
Questi gioielli non solo rendono il busto reliquiario un’opera d’arte straordinaria, ma raccontano anche la storia della devozione e del legame tra Sant’Agata e le personalità illustri del tempo, oltre che quello dei cittadini e dei fedeli di ogni parte del mondo.


Il velo
Il velo di Sant’Agata è una reliquia conservata nella Cattedrale di Catania in uno scrigno d’argento insieme ad altre reliquie della giovane. Nella storia, il cosiddetto velo di colore rosso faceva parte del vestimento con cui Agata si presentò al giudizio, essendo questo, indossato su una tunica bianca, l’abito delle diaconesse consacrate a Dio.
Nel corso dei secoli, il “mistico velo” fu più volte portato in processione come estremo rimedio per fermare la lava dell’Etna diretta sulla città, i terremoti e diverse epidemie di peste: grazie all’intercessione della Santa, Catania fu sempre risparmiata.
La festa di Sant’Agata per i Catanesi
La Festa di Sant’Agata, che si svolge ogni anno dal 3 al 5 febbraio a Catania, è una delle celebrazioni religiose più grandi del mondo. I festeggiamenti includono processioni, messe solenni, fuochi d’artificio e una folla di devoti che indossano il tradizionale “sacco agatino” ovvero una tunica bianca (simbolo di purezza) una papalina nera (simbolo di penitenza) e guanti bianchi in onore della Santa.
Uno dei momenti più salienti della festa è “La Messa dell’Aurora”, celebrazione liturgica tenuta nelle prime ore di giorno 4 Febbraio (da qui il nome) che rievoca il rientro delle reliquie nella città.
Dopo la celebrazione, il busto e le reliquie di Sant’Agata vengono portate in processione per le vie della città per mezzo di un grande fercolo in argento. Tale fercolo è decorato con garofani rossi nel giorno del 4 Febbraio, rappresentando il giorno del martirio, mentre con garofani bianchi nel giorno della sua morte ed ascensione, avvenuta il 5 Febbraio.
Il suo cammino è preceduto ed illuminato dalle tradizionali Candelore, simbolo di devozione dei catanesi e delle categorie storiche o corporazioni. Numerosi sono i devoti, i catanesi ed in generale i fedeli che da ogni parte del mondo vengono per adorare la martire e rivolgerle le loro preghiere, considerando Sant’Agata come un simbolo di lotta contro la violenza sulle donne.

Sant’Agata come simbolo di lotta contro la violenza sulle donne
Il martirio di Sant’Agata, in particolare il gesto atroce di strappare i suoi seni, rappresenta la brutalità e la violenza che le donne hanno subito, e purtroppo, in certi casi, continuano a subire. Tuttavia, il suo coraggio e la sua resistenza continuano a ispirare e a offrire speranza a coloro che soffrono, rappresentando un esempio di forza e di fede di fronte alle avversità.
In questo modo, oltre che essere venerata come figura religiosa, Sant’Agata è considerata il simbolo di lotta contro la violenza sulle donne e un’ispirazione per coloro che si battono per i loro diritti e la loro dignità.
Inno in onore di Sant’Agata
Inneggiamo alla martire invitta
rifulgente di luce divina
inneggiamo alla grande eroina
presso l’ara cosparsa di fior.
Anelante di palpiti sacri
si diffonda la gioia nel cielo
ed all’ombra del mistico velo
sorga l’inno festoso dei cuor.
Rit.
Tu che splendi in paradiso
coronata di vittoria,
o sant’Agata, la gloria
per noi prega di lassù.
Esultante nei duri tormenti
luminosa nel carcere oscuro
ella affronta con animo puro l
e minacce di un uomo crudel;
non ascolta le vane lusinghe
le promesse d’un sogno radioso
vince il fuoco e del cielo armonioso
l’innamora l’eterno splendor.
Per i secoli vola il suo nome
e risuona pei monti e sul mare
circonfuso di sole l’altare
il suo corpo conserva fedel.
Su! Leviam, cittadini, l’evviva al valor centenario,
possente di colei che pregava morente
il Signor della vita immortal.